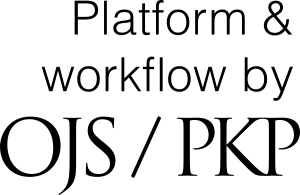Aspetti di vita quotidiana nei castelli del Friuli medievale: dati archeologici preliminari
Downloads
Pubblicato
Fascicolo
Sezione
Licenza
Copyright (c) 2025 Simonetta Minguzzi

Questo lavoro è fornito con la licenza Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0.
La licenza adottata è la Creative Commons - Attribuzione/Condividi allo stesso modo. Ovvero, gli autori che pubblicano su questa rivista accettano le seguenti condizioni:
- Gli autori mantengono i diritti sulla loro opera e cedono alla rivista il diritto di prima pubblicazione dell'opera, contemporaneamente licenziata sotto una Licenza Creative Commons - Attribuzione che permette ad altri di condividere l'opera indicando la paternità intellettuale e la prima pubblicazione su questa rivista.
- Gli autori possono aderire ad altri accordi di licenza non esclusiva per la distribuzione della versione dell'opera pubblicata (es. depositarla in un archivio istituzionale o pubblicarla in una monografia), a patto di indicare che la prima pubblicazione è avvenuta su questa rivista.
- Gli autori possono diffondere la loro opera online (es. in repository istituzionali o nel loro sito web) prima e durante il processo di submission, poiché può portare a scambi produttivi e aumentare le citazioni dell'opera pubblicata.
DOI:
https://doi.org/10.13138/2039-2362/3728Parole chiave:
Friuli, castelli, ceramiche, vetri, sistemi igieniciAbstract
Le indagini archeologiche svolte nei castelli del Friuli Orientale (castelli di Ahrensperg, Motta, Partistagno, Zucco) hanno restituito molti dati riguardo la vita di questi insediamenti dal XIII al XVI secolo. Si considerano qui aspetti di vita quotidiana derivanti da alcuni contesti chiusi in relazione anche con la destinazione d’uso degli spazi: focolari, recipienti per cottura e preparazione dei cibi, suppellettili per la tavola, aspetti igienici. Dall’analisi preliminare appare evidente l’alto livello di qualità di vita presente nei castelli basso medievali, residenze dell’alta nobiltà friulana, evidenziata da importazioni di ceramiche dall’area bizantina e islamica, di raffinate produzioni vitree veneziane, da un sistema igienico pari a quello riscontrato nelle più importanti dimore urbane dell’area alto adriatica. Nel corso del XV secolo si nota una progressiva diminuzione e impoverimento dei materiali in uso alle classi subalterne, le sole ancora presenti all’interno dei castelli.
Riferimenti bibliografici
Biasi A., Piuzzi F., a cura di (1994), Scharfenberg-Soffumbergo, un castello tedesco nel Friuli medievale, Pasian di Prato UD: ETC. Editoria, Comunicazione et Cetera
Biasin L., Francescutto M. (2015), Il castello di Partistagno (Attimis - UD). Evoluzione di un complesso fortificato basso medievale, in Pagano 2015, pp. 88-103.
Binutti R. (1998), Attimis e i suoi castelli, Udine: Arti grafiche friulane.
Borzacconi A. (2011), Ceramica dallo scavo di via Brenari (= Archeologia di frontiera, 8), Trieste: Editreg.
Buora M., Tomadin V. a cura di (1993), Ceramiche rinascimentali a Udine, (= Cataloghi e monografie archeologiche dei Civici Musei di Udine, 4), Roma: “L’Erma” di Bretschneider.
Buora M., Leonarduzzi A., Nonini G., Saccavini A., (2000), Lo scavo entro Palazzo Ottelio, in Le mattonelle rinascimentali di Palazzo Ottelio, a cura di P. Casadio, G. Malisani, S. Vitri, Relazioni della SBAAAAS FVG 12, Udine, pp. 20-30.
Colussa S., Tomadin V. a cura di (2000), Castrum de Harperch apud Manzanum (1251- 1431). Manzano e il suo castello: ricerche storiche e indagini archeologiche, Udine: Arti Grafiche.
Cozza F. (1988), Ceramiche e vetri dei secoli XIV-XV nel palazzo già Dondi dall’Orologio a Padova, «Archeologia Veneta», XI, pp. 171-239.
Ericani G. a cura di (1986), Il ritrovamento di Torretta per uno studio della ceramica padana, Venezia: Cataloghi Marsilio.
Favia L., Malagola G., Testori G., Tomadin V. (1992), Le campagne di scavo al castello di Zuccola in Cividale del Friuli, «Archeologia Medievale», XIX, pp. 243-277.
Gelichi S. (1992A), Igiene e smaltimento dei rifiuti: le buche di scarico di piazzetta Castello, in Ferrara prima e dopo il Castello, a cura di S. Gelichi, Ferrara: Spazio Libri, pp. 66-98.
Gelichi S. (1992B), Una discarica di scarti di fornace e la graffita ferrarese del XV secolo, in Ferrara prima e dopo il Castello, a cura di S. Gelichi, Ferrara: Spazio Libri, pp. 260-288.
Gelichi S. (2003), Cerami di importazione e ceramica rivestita “arcaica”, in Progetto castello della Motta di Savorgnano, a cura di F. Piuzzi, Firenze: All’Insegna del Giglio, pp.151-154.
Gelichi S., Piuzzi F., Cianciosi A., a cura di (2008), “Sachuidic presso Forni Superiore”. Ricerche archeologiche in un castello della Carnia, Firenze: All’Insegna del Giglio.
Guarnieri C., a cura di (2009A), Il bello dei butti. Rifiuti e ricerca archeologica a Faenza tra Medioevo ed Età Moderna, Firenze: All’Insegna del Giglio.
Guarnieri C., a cura di (2009B), Il Monte prima del Monte. Archeologia e storia di un quartiere medievale di Forlì, Bologna: AnteQuem.
Guarnieri C. (2012), Rifiuti, butti ed altre immondizie: dalla formazione dei depositi allo studio archeologico. Il caso dell’Emilia Romagna, in Dal butto alla storia. Indagini archeologiche tra Medioevo e Postmedioevo, a cura di M. Milanese, V. Caminneci, M.C. Parello, M.S. Rizzo, «Archeologia Postmedievale», 16, pp. 165-179.
Lusuardi Siena S., Negri A. (2007), A proposito del vasellame friulano con marchio a rilievo sul fondo tra tarda antichità e medioevo, in La circolazione delle ceramiche nell’Adriatico tra tarda antichità e alto medioevo, a cura di S. Gelichi, C. Negrelli, Mantova: SAP Società Archeologica, pp. 183-214.
Magrini C., Zenarolla L. (2023), A tavola e in cucina tra Medioevo e Rinascimento nel castello di San Vito al Tagliamento (PN), Sesto Fiorentino: All’Insegna del Giglio.
Mandruzzato L., a cura di (2008), Vetri antichi del Museo archeologico nazionale di Aquileia. Ornamenti e oggettistica di età romana, vetro pre- e post-romano. Corpus delle collezioni del vetro nel Friuli Venezia Giulia, 4, Trieste: Editreg.
Mingotto L., Moro M.A. (1989), Restauro di un edificio del XVI secolo a Oderzo (TV). Analisi di un impianto di scarico ad uso domestico. Nota preliminare, «Archeologia Uomo Territorio», 8, pp. 101-112.
Minguzzi S. (2015), Il castello di Ahrensperg (Pulfero). Dai Barbari all’Italcementi, in Pagano 2015, pp. 152-163.
Minguzzi S. (2019),…et in reliquis castellis. Gli scavi dell’Università di Udine nei castelli del Friuli (2003-2014), «Quaderni Friulani di Archeologia», XXIX, 1, pp. 169-182.
Minguzzi S. 2022, Lo smaltimento dei rifiuti e i sistemi igienici nei castelli del Friuli medievale. Dati archeologici preliminari, in Atti del IX Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (Alghero - SS, 28 settembre – 2 ottobre 2022), a cura di M. Milanese, 2, Sesto Fiorentino: All’Insegna del Giglio, pp. 331-335.
Minguzzi S. (2024), Il castello della Motta nel Friuli medievale: il contesto archeologico, in Primissima infanzia in paleopatologia, Atti della Giornata di studi multidisciplinare (Udine, 1-2 dicembre 2023), a cura di P. Cosmacini, N. Nicoli Aldini, P. Saccheri, «Nuova Rivista di Storia della medicina», pp. 65-72.
Minguzzi S., Biasin L., Francescutto M. (2013), Il castello di Partistagno (Attimis, UD). Sintesi delle ricerche e aggiornamenti, in «Forum Iulii», XXXVII, pp. 119-135.
Minguzzi S., Piuzzi F., Travan L., Saccheri P. (2022), Il mistero del pozzo. Ultimi ritrovamenti nel castello della Motta di Savorgnano, in Cultura in Friuli VII, Atti della Settimana della cultura friulana (18-28 ottobre 2020 / 6-16 maggio 2021), a cura di M. Varutti, M.C. Visintin, Udine: Società Filologica Friulana, pp. 417-426.
Pagano F. a cura di (2015), Fortini antichi erano all’intorno di Cividale. Archeologia e castelli del Friuli nord-orientale (= Percorsi di archeologia, 6), Trieste: Luglio editore.
Piuzzi F. (2002), Prime indagini archeologiche nel castello di Partistagno (Attimis-UD), campagne 1999-2000, in «Archeologia Medievale», XXIX, pp. 421-433.
Piuzzi F., a cura di (2003), Progetto castello della Motta di Savorgnano, Firenze: All’Insegna del Giglio.
Piuzzi F., a cura di (2007), Il pozzetto USM 438. Uno squarcio sulla vita quotidiana nel XIII secolo (= Quaderni della Motta, 2), Pasian di Prato: Edizioni dell’Accademia.
Piuzzi F. (2015), Il castello di Romeo e Giulietta. La rappresentazione della storia nel recupero e valorizzazione della Motta di Savorgnano, in Pagano 2015, pp. 58-72.
Sabbionesi L. (2019), “Pro maiore sanitate hominorum civitatis…et borgorum”. Lo smaltimento dei rifiuti nelle città medievali dell’Emilia Romagna, Firenze: All’Insegna del Giglio.
Travan L., Saccheri P. (2024), Non voluto: il neonato del castello della Motta, in Primissima infanzia in paleopatologia, Primissima infanzia in paleopatologia, Atti della Giornata di studi multidisciplinare (Udine, 1-2 dicembre 2023), a cura di P. Cosmacini, N. Nicoli Aldini, P. Saccheri, «Nuova Rivista di Storia della medicina», pp. 73-85.
Villa L., a cura di (2010),…pro costruendo Castrum et Domum de Laurentino… Il castello di Toppo. Un progetto di recupero e valorizzazione tra archeologia e restauro, (= NordAdriatica - Studi e ricerche di archeologia della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia), Spilimbergo: Comune di Travesio.
Vitri S., Casadio P., a cura di (2001), Magistri scodelari. Produzioni ceramiche a Castelnovo del Friuli nel Cinquecento, Tavagnacco: Art grafiche friulane.