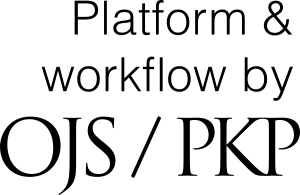Informazioni per gli autori
Dati essenziali
Ogni contributo deve essere accompagnato dai seguenti dati:
Nome e Cognome dell’autore:
Nazionalità:
Università di appartenenza:
Dipartimento:
Città:
Stato:
Indirizzo di posta elettronica istituzionale:
Abstract in italiano e in inglese, per un massimo di 800 + 800 battute spazi inclusi
Indicazioni redazionali per gli autori
La redazione accetta articoli nelle principali lingue di comunicazione scientifica.
Gli articoli vanno elaborati in formato digitale (file .doc o .rtf), contenendone la lunghezza entro le 60.000 battute (spazi inclusi). Possono essere recapitati all’indirizzo di posta elettronica giornalecostituzionale@unimc.it oppure registrati su supporto elettronico (Cd-Rom) e inviati per posta ordinaria all’indirizzo della Redazione: Giornale di Storia costituzionale, Dipartimento di diritto pubblico e teoria del governo, Università degli Studi di Macerata, piazza Strambi, 1 – 62100 Macerata, Italia.
L’eventuale materiale iconografico va consegnato in file separati, nominati in modo da indicarne la sequenza. Le immagini (formato .tiff o .jpeg) dovranno avere una risoluzione di almeno 300 dpi e una larghezza alla base di almeno 70mm; grafici e tabelle dovranno essere consegnati nel formato originale di elaborazione, con una larghezza non superiore ai 133mm. In un apposito file di testo vanno invece riportate le didascalie relative a ciascuna immagine, tabella o grafico.
Norme editoriali
Titoli. Evitare l’uso del maiuscolo o del maiuscoletto. I titoli dei contributi e degli abstracts vanno riportati anche in inglese. I titoli di paragrafi e sottoparagrafi debbono essere numerati, con numerazione progressiva in cifre arabe. Il punto finale non va messo in nessun caso.
Redazione del testo. La formattazione del testo deve essere minima. Si richiede soltanto che siano riconoscibili gli elementi che compongono il contributo: il titolo, i titoli dei paragrafi e dei sottoparagrafi, il corpo del testo, le citazioni, le note e la collocazione degli eventuali materiali di corredo (immagini, grafici e tabelle). Vanno evitate tutte le istruzioni/impostazioni‘superflue’ ai fini della comprensione dei contenuti, che pure rendono meno agevole il trattamento del file. Da evitare la formattazione automatica, la giustificazione, l’uso degli elenchi numerati (o puntati) da programma, l’utilizzo del trattino e del tasto invio per la sillabazione. Evitare anche la sillabazione automatica; è sufficiente allineare il testo a sinistra. Usare il ritorno a capo (tasto invio) solo per chiudere il paragrafo. Rispettare la funzione e la gerarchia delle virgolette; limitare l’uso dei corsivi e, se possibile, evitare quello dei grassetti e dei sottolineati.
Si scelga font comuni (arial, times, verdana) e si segnali – in una nota per la redazione – l’eventuale utilizzo di caratteri speciali. Per ulteriori indicazioni si veda di seguito.
Citazioni. Le citazioni lunghe (superiori a 3-4 righe) vanno staccate dal testo (precedute e seguite da uno spazio), senza essere racchiuse da virgolette, composte in corpo minore e sempre in tondo.
Le citazioni brevi vanno incorporate nel testo e poste fra virgolette basse (o caporali) « »; eventuali citazioni interne alla citazione vanno poste fra virgolette doppie alte “ ”, sempre in tondo.
Note. Le note al testo sono destinate essenzialmente a mero rinvio bibliografico e a fini esplicativi. Si raccomanda di contenere al massimo il numero delle note. In ogni caso, le battute relative alle note (spazi inclusi) non devono superare il terzo delle battute complessive del testo (nel caso di un testo standard di 60.000, spazi inclusi, le note non dovranno superare le 20.000 battute).
Il rimando alle note, all’interno del testo, va elaborato automaticamente e va collocato prima della punteggiatura (salvo i casi dei punti esclamativo, interrogativo e di sospensione). Anche se si tratta di note di chiusura (e non a piè di pagina), i riferimenti nel testo non vanno in nessun caso creati assegnando l’apice a un numero posto manualmente, ma solo utilizzando l’apposita funzione del programma di video scrittura (che automaticamente genera il numero e colloca il testo di nota; in Word, dal menù Inserisci > riferimento). Il punto chiude sempre il testo delle note.
Indicazioni bibliografiche. I dati bibliografici di un’opera citata vanno in nota.
Nella prima citazione debbono essere completi dei seguenti elementi, nell’ordine indicato.
– se si tratta di un’opera compiuta: iniziale puntata del nome e cognome dell’autore (con solo le iniziali in maiuscolo e mai in maiuscoletto); titolo in corsivo; luogo; editore; anno (in apice, l’eventuale segnalazione del numero dell’edizione citata). Tutti questi elementi saranno separati l’uno dall’altro mediante virgole. Sempre mediante la virgola, vanno separati i nomi degli autori in un’opera a più mani. Nel caso in cui l’autore abbia un nome doppio, le iniziali vanno indicate senza lo spazio separatore. L’a cura di va riportato (tra parentesi tonde) nella lingua di edizione del testo, subito dopo il nome del curatore e con la virgola solo dopo la parentesi di chiusura. Se viene indicata una parte della pubblicazione, va aggiunta la pagina (o le pagine) di riferimento. Qualora si tratti di un’opera in più volumi, l’indicazione del volume (preceduta da ‘vol.’) va anteposta ai numeri di pagina. Esempi:
F. Jahn, Deutsches Volksthum, Lübeck, Niemann & Co, 1810.
L. Pegoraro, A. Rinella, Le fonti del diritto comparato, Torino, Giappichelli, 2000.
R.D. Edwards, The Best of Bagehot, London, Hamish Hamilton, 1993, p. 150.
A. King (edited by), The British Prime Minister, London, Macmillan, 19852, pp. 195-220.
Scritti in onore di Gaspare Ambrosini, Milano, Giuffrè, vol. III, pp. 1599-1615.
– se si tratta di un’opera tradotta: iniziale puntata del nome e cognome dell’autore; titolo originale dell’opera in corsivo; anno di pubblicazione tra parentesi tonde, seguito dal ‘punto e virgola’; l’abbreviazione che introduce il titolo della traduzione ‘tr. it.’ (o ‘tr. fr.’, ‘tr. es.’ etc.); titolo della traduzione in corsivo; luogo; editore; anno. Esempi:
W. Benjamin, Über den Begriff der Geschichte (1940); tr. it. Sul concetto di storia, Torino, Einaudi, 1997.
J.S. Mill, Considerations on Representative Government (1861); tr. it. Considerazioni sul governo rappresentativo, Roma, Editori Riuniti, 1999.
– se si tratta di un contributo che compare in un volume miscellaneo: iniziale puntata del nome e cognome dell’autore del contributo; titolo del contributo in corsivo; nome (puntato) e cognome del curatore/autore del volume, preceduto da ‘in’ ed eventualmente seguito da (a cura di); titolo del volume in corsivo; luogo; editore; anno; paginazione del contributo. Esempi:
G. Miglio, Mosca e la scienza politica, in E.A. Albertoni (a cura di), Governo e governabilità nel sistema politico e giuridico di Gaetano Mosca, Milano, Giuffrè, 1987, pp. 15-17.
O. Hood Phillips, Conventions in the British Constitution, in Scritti in onore di Gaspare Ambrosini, Milano, Giuffrè, vol. III, pp. 1599 s.
– se si tratta di un contributo che compare in una pubblicazione periodica: nome dell’autore e titolo dell’articolo (riportati come in tutti gli altri casi); testata del periodico tra virgolette caporali preceduta da ‘in’; (ove presenti) indicazione dell’annata (in numeri romani) e numero del fascicolo preceduto da ‘n.’ (e non da n°, N., num. etc.); anno di pubblicazione; numero pagina/e. Nel caso di citazione da un quotidiano, dopo il titolo della testata si metta la data per esteso. Nel caso si faccia riferimento ad articoli pubblicati in riviste online, si dovrà fornire l’indirizzo esatto del testo (o, in alternativa, della pagina principale del sito che lo rende disponibile) e la data di consultazione. Esempi:
G. Bonacina, Storia e indirizzi del conservatorismo politico secondo la dottrina dei partiti di Stahl, in «Rivista storica italiana», CXV, n. 2, 2003.
A. Ferrara, M. Rosati, Repubblicanesimo e liberalismo a confronto. Introduzione, in «Filosofia e Questioni Pubbliche», n. 1, 2000, pp. 7 ss.
S. Vassallo, Brown e le elezioni. Il dietrofront ci insegna qualcosa, in «Il Corriere della Sera», 9 ottobre 2007, p. 42.
G. Doria, House of Lords: un nuovo passo sulla via della riforma incompiuta, in «federalismi.it», n. 4, 2007, <http://fede ralismi.it>, settembre 2010.
I dati bibliografici dovranno essere completi solo per il primo rimando; per i successivi si procederà indicando solo il cognome dell’autore/curatore; il titolo (o una parte) in corsivo e seguito dall’abbreviazione ‘cit.’ o ‘tr. cit.’ (nel caso di opere tradotte); l’indicativo delle pagine. Di seguito gli esempi per le diverse tipologie di:
Jahn, Deutsches Volksthum cit., pp. 45, 36.
Pegoraro, Rinella, Le fonti del diritto cit., p. 200.
King, The British Prime Minister cit., p. 195.
Benjamin, Über den Begriff tr. cit., pp. 15-20, 23.
Bonacina, Storia e indirizzi del conservatorismo politico cit., p. 19.
Ferrara, Rosati, Repubblicanesimo cit., pp. 11 ss.
Doria, House of Lords cit.
Nel caso si rimandi alla stessa opera e alla stessa pagina (o pagine) citate nella nota precedente si può usare ‘Ibidem’ (in corsivo), senza ripetere nessuno degli altri dati; se invece si rimanda alla stessa opera citata nella nota precedente, ma a un diverso numero di pagina, si usi ‘Ivi’, seguito dal numero di pagina.
ULTERIORI INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL TESTO
Rimandi interni al volume. Non debbono mai riferirsi a numeri di pagina; si può invece rimandare a sezioni di testo, interi contributi e paragrafi o immagini (opportunamente numerati).
Paginazione. Nei riferimenti bibliografici, il richiamo al numero o ai numeri di pagina deve essere sempre preceduto (rispettivamente) da p. o pp. e riportato per intero; quindi, ad es., pp. 125-129 e non pp. 125-9. Qualora non si tratti di pagine consecutive, i numeri vanno separati dalle virgole: per es. pp. 125, 128, 315. Per indicare anche la pagina seguente o le pagine seguenti si utilizzi rispettivamente s. o ss. (quindi senza ‘e’ precedente) e non sgg., seg. o formule analoghe.
Date. Riportando le date, l’autore può adottare il criterio che ritiene più adeguato, purché rispetti rigorosamente l’uniformità interna all’articolo. Nel caso vengano utilizzate forme abbreviate, il segno per l’elisione è l’apostrofo e non la virgoletta alta di apertura (per es. ’48 e non ‘48).
Sigle e acronimi. Le sigle devono sempre comparire senza punti tra le lettere e, la prima volta in cui sono citate, vanno fatte seguite dalla dicitura per esteso e dall’eventuale traduzione tra parentesi. Non occorre l’esplicitazione delle sigle di uso comune (come USA, NATO, ONU, UE, etc.).
Punti di sospensione o elisione. Sono sempre 3, quindi non si rendono digitando tre volte il punto sulla tastiera ma inserendo l’apposito simbolo. Quando indicano sospensione – come ogni segno di punteggiatura – vanno staccati dalla parola che segue e attaccati alla parola che li precede (ad esempio … non mi ricordo più…). Non richiedono il punto finale.
Quando indicano elisione, quindi un taglio o una lacuna nel testo, il simbolo viene incluso tra parentesi quadre, in questo modo […].
Trattini. Il trattino medio viene usato, seguito e preceduto da spazio, per aprire e chiudere gli incisi. Quando il trattino di chiusura dell’inciso coincide con la chiusura della frase, si omette e si inserisce solo il punto fermo. Ad es. … testo – inciso che chiude anche la frase.
Il trattino breve si usa solo per i termini compositi formati da parole intere (ad es. centro-sinistra) e per unire due quantità numeriche (ad es. pp. 125-148); sempre senza spazi prima e dopo.
Virgolette. Le virgolette basse « » (caporali) si usano per indicare il discorso diretto, le citazioni brevi e, nei riferimenti bibliografici, per i titoli delle pubblicazioni periodiche. Le virgolette alte “ ”, invece, per le parole di uso comune a cui si vuole dare particolare enfasi (o assunte prescindendo dal loro significato abituale). Inoltre, nelle citazioni di titoli di quotidiani, periodici, riviste oppure di capitoli e sezioni di paragrafi di un libro (ad es. … come indicato nel paragrafo “La Germania assassinata” della Storia dell’età moderna…). Infine, quando è necessario fare uso delle virgolette all’interno di un discorso già tra caporali. La gerarchia è la seguente: «… “… ‘…’ …” …». I segni di punteggiatura (salvo il punto esclamativo o interrogativo quando fanno parte della citazione) vanno sempre posposti alla chiusura delle virgolette.
Rimandi al web. Quando si fa riferimento a contenuti online, bisogna sempre indicare in maniera completa l’indirizzo (compreso il protocollo http:// o ftp:// etc.; possibilmente senza spezzarlo) e racchiuderlo tra i segni minore e maggiore; va indicata sempre anche la data di consultazione o di verifica (dell’indirizzo). Altro dato indispensabile è il titolo (o nome) del sito/pagina o una breve descrizione dei contenuti che si troveranno all’indirizzo riportato. Quindi, ad esempio, un riferimento corretto può essere così formulato: Sezione novità delle Edizioni Università di Macerata, <http://eum.unimc.it/novita>, giugno 2010.