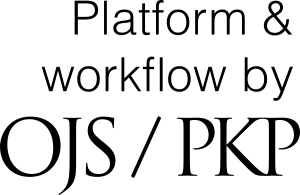L'abbazia di Santa Croce al Chienti: note per un’analisi del patrimonio fondiario / The Abbey of Santa Croce al Chienti: Notes for an Analysis of the Landed Property
Downloads
Pubblicato
Versioni
- 2025-07-09 (4)
- 2025-07-09 (3)
- 2025-06-30 (2)
Fascicolo
Sezione
Licenza
Copyright (c) 2025 alessia frisetti

Questo lavoro è fornito con la licenza Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0.
La licenza adottata è la Creative Commons - Attribuzione/Condividi allo stesso modo. Ovvero, gli autori che pubblicano su questa rivista accettano le seguenti condizioni:
- Gli autori mantengono i diritti sulla loro opera e cedono alla rivista il diritto di prima pubblicazione dell'opera, contemporaneamente licenziata sotto una Licenza Creative Commons - Attribuzione che permette ad altri di condividere l'opera indicando la paternità intellettuale e la prima pubblicazione su questa rivista.
- Gli autori possono aderire ad altri accordi di licenza non esclusiva per la distribuzione della versione dell'opera pubblicata (es. depositarla in un archivio istituzionale o pubblicarla in una monografia), a patto di indicare che la prima pubblicazione è avvenuta su questa rivista.
- Gli autori possono diffondere la loro opera online (es. in repository istituzionali o nel loro sito web) prima e durante il processo di submission, poiché può portare a scambi produttivi e aumentare le citazioni dell'opera pubblicata.
DOI:
https://doi.org/10.13138/2039-2362/3723Abstract
Lo studio della valle del Chienti, con particolare attenzione ai complessi architettonici religiosi, ha preso il via su incoraggiamento di Umberto Moscatelli, con l’obiettivo di approfondire alcuni temi già affrontati in seno al progetto R.I.M.E.M. Percorrendo la valle in diverse occasioni è nato poi l’interesse verso l’abbazia di Santa Croce al Chienti ed in particolare per il suo patrimonio fondiario. Quest’ultimo è stato analizzato a partire dalle fonti documentarie e cartografiche edite, con l’obiettivo di individuare, attraverso ripetuti sopralluoghi, i beni in godimento all’abbazia, analizzarne la natura e comprenderne le dinamiche di gestione attuate dalla comunità religiosa. Il risultato più apprezzabile, oltre ad una preliminare messa a sistema del patrimonio – per il quale permangono ancora diverse incertezze in termini di localizzazione topografica dei beni stessi – è probabilmente la ricostruzione di un paesaggio monastico che tra IX e XII secolo appare più vivo ed in fermento che mai.
TThe study of the Chienti valley, with particular attention to the religious architectural complexes, began at the encouragement of Umberto Moscatelli, with the aim of deepening certain themes already addressed within the R.I.M.E.M. project. Travelling through the valley on various occasions, interest was then aroused in the abbey of Santa Croce al Chienti and in particular its land patrimony. The latter was analysed on the basis of ancient written and cartographic sources, with the aim of identifying, through repeated surveys, the assets enjoyed by the abbey, analysing their nature and understanding the management dynamics implemented by the religious community. The most appreciable result, in addition to a preliminary systematisation of the patrimony - for which there are still several uncertainties in terms of the topographical location of the goods themselves - is probably the reconstruction of a monastic landscape that between the 9th and 12th centuries appears more alive and in ferment than ever.
Riferimenti bibliografici
Accardo A. M. (2009), I documenti di Santa Croce nelle carte dell’Archivio di Sant’Elpidio a Mare, Casette d’Ete: Grafiche Fioroni.
Andreolli B. (2006), La patrimonialità del monastero di San Silvestro di Nonantola tra alto e basso medioevo, in Monasteri d’Appennino, Atti della giornata di studio (Capugnano, 11 settembre 2004), a cura di R. Zagnoni, Pistoia, pp.21-54.
Andreolli B. (2000), Situazioni proprietarie, situazioni possessorie. Spunti per un dibattito europeo sulla contrattualistica agraria altomedioevale, in Per Vito Fumagalli. Terra, uomini, istituzioni medievali, a cura di M. Montanari, A. Vasina, Bologna: Clueb, pp. 539-560.
Andreolli B. (1999), Contadini su terre di signori. Studi sulla contrattualistica agraria dell’Italia medievale, Bologna: Clueb.
Antongirolami V, 2005, Materiali per la storia dell’incastellamento nelle Marche meridionali. La Valle del Chienti, in «Archeologia Medievale», XXXIII, 2005, All’Insegna del Giglio: pp. 333-363.
Avarucci G. (1997), Introduzione a Le carte dell’Abbazia di Chiaravalle di Fiastra. III (1201-1216), Spoleto: Fondazione CISAM.
Avarucci G., Borri G., (2004), Introduzione a Le carte dell’Abbazia di Chiaravalle di Fiastra. VII (1247-1255), Spoleto: Fondazione CISAM.
Bartolazzi P.P. (1887), Montolmo (oggi città di Pausola). Sua origine incrementi e decadenza nel Medio Evo e nel Cinquecento, Pausula: Tipografia Success. Crocetti.
Borri G. (2006), Le pergamene di Chiaravalle di Fiastra (1006-1255), in «Studia Picena», LXXI, Antiqui, pp. 49-92.
Borri G. (2006a), Montegranaro castello del contado di Fermo dalle origini al XV secolo, Roma: Istituto storico dei Cappuccini, pp. 451-489.
Borri G. (2004), Documenti per la storia del monastero di Santa Croce al Chienti (1085-1291), in «Studia Picena», LXIX, Antiqui pp.7-87.
Borri G. (1998), Introduzione a Le carte dell’Abbazia di Chiaravalle di Fiastra. V (1231-1337), Spoleto: Fondazione CISAM.
Carboni F. (2014), Schede di sito in Treia (R. Perna, F. Carboni), in Carta Archeologica della Provincia di Macerata (CAm-M), a cura di R. Perna, S. Finocchi, C. Capponi, Macerata: EUM Edizioni Università di Macerata, pp. 481-498.
Catalani M. (1795), De ecclesia firmana. I vescovi e gli arcivescovi della Chiesa fermana. Commenatrio secc. III-XVIII, Fermo.
Cherubini A.(1992), Territorio e abbazie nelle Marche, in Abbazie delle Marche. Storia e Arte, a cura di E. Simi Varanelli, Roma: Andrea Livi Editore, pp. 249-362.
D’Amico A. (2003), Rilettura di un’opera del medioevo marchigiano: l’abbazia di S. Croce al Chienti, in «Palladio», 16 2003 (2004), 32 ???, pp. 5-16.
De Luca A. (2013), Introduzione a Le carte dell’abbazia di Chiaravalle di Fiastra. II (1181-1200), Spoleto: Fondazione CISAM.
De Luca A. (1997), Introduzione a Le carte dell’abbazia di Chiaravalle di Fiastra. I (1006-1180), Spoleto: Fondazione CISAM.
Digeva A. (2016), Cluana, in «Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche», XXI, n.199, pp. ???.
Ghignoli A. (1998), Note intorno all’origine di uno ius libellarium, Firenze: Leo Olschki Editore, 1998.
Gigliozzi M.T. 2020, Edifici di culto nelle Marche sullo scorcio dell’alto Medioevo: valori, criticità e prospettive della ricerca, in «Marca/Marche» 14, pp. 79-96.
Giorgi E. (1999), La bassa valle del Chienti: il territorio di Cluana in età romana, in Atta 8, Campagna e paesaggio nell’Italia antica, Roma: L’Erma di Bretschneider, pp. 165-184.
Grelli M. E. (2006), I Monaci benedettini di Farfa nel Piceno: signoria territoriale e rapporti di potere tra VIII e XI secolo, in Farfa abbazia imperiale, Atti del Convegno internazionale (S. Vittoria in Matenano, 25-29 agosto 2003), a cura di R. Dondarini, Negarine (San Pietro in Cariano): Gabrielli Editori, pp. 69-100.
Hagemann W. (1964), Studien und Dokumente zur Geschichte der Marken im Zeitalter der Staufer. III. Sant’Elpidio a Mare, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 44 (1964), pp. 72-151.
Hagemann W. (1961), Studien und Dokumente zur Geschichte der Marken im Zeitalter der Staufer, II, Chiaravalle di Fiastra, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», XLI (1964), pp. 48-136.
Maraviglia C., a cura di (2001), Le carte dell’Abbazia di Chiaravalle di Fiastra. IV (1217-1230), Spoleto, Fondazione CISAM.
Martin J-M. (1994), Città e campagna: economia e società (sec. VII-XII), in Storia del Mezzogiorno. L’Alto Medioevo, Foggia: Edizioni del Sole, pp. 259-354.
Marazzi F. (2019), Dalle valli ai litorali. Riflessioni sui rapporti fra cose ed entroterra in Italia centrale dall’VIII all’XI secolo, in Medioevo delle Valli. Insediamento, società, economia nei comprensori di valle tra Alpi e Appennini (VIII-XIV sec.), a cura di F. Marazzi, C. Raimondo, Cerro a Volturno (IS): Volturnia Edizioni, pp. 283-314.
Marazzi F. (2011), San Vincenzo al Volturno dal X al XII secolo. Le “molte vite” di un monastero fra poteri universali e trasformazioni geopolitiche del Mezzogiorno, Roma: Istituto Storico Italiano per il Medio Evo.
Minguzzi S., Moscatelli U., Sogliani F. (2003), Prime note sulle dinamiche insediative tra età tardoantica e medioevo nella Marca meridionale, in III Congresso della Società degli Archeologi Medievisti Italiani (Salerno, 2-5 ottobre 2003), Firenze, pp. 594-599.
Moscatelli U. (1988), Treia, in Forma Italiae, 33, Roma: Edizioni Quasar.
Moscatelli U. (2019), Le vallate interne delle Marche centro-meridionali tra antichità e Medioevo: una trama da costruire, in Medioevo delle Valli. Insediamento, società, economia nei comprensori di valle tra Alpi e Appennini (VIII-XIV sec.), a cura di F. Marazzi, C. Raimondo, Cerro a Volturno (IS): Volturnia Edizioni, pp. 181-195.
Moscatelli U. (2022), Storie di mari, di fiumi e laghi d’altri tempi, in La Luna e il Picchio, a cura di, U. Moscatelli, in «Marca Marche», 19, pp. 9-23.
Perna R (2014), Analisi diacronica della viabilità in età romana, in Carta Archeologica della Provincia di Macerata (CAm-M), a cura di R. Perna, S. Finocchi, C. Capponi, Macerata: EUM Edizioni Università di Macerata, pp. 141-154.
Pirani F., 2011 (a cura di), Wolfgang Hagemann. Studi e documenti per la storia del fermano nell’età degli Svevi (secoli XII-XIII), Fermo: Livi Editore, pp. 277-284.
Piva P. (2012), Il romanico nelle Marche, Milano: Jaka Book.
Piva P. (2003), Marche romaniche, Milano: Jaka Book.
Pirani F. (2014), Città, insediamenti costieri e strutture portuali nel medio Adriatico, in Attività economiche e sviluppi nell’Italia dei secoli XI-XV, a cura di E. Lusso, Cherasco: CISIM, pp. 161-187.
Pirani F. (2010), Fermo, Spoleto: Fondazione CISAM.
Pivano S. (1906), Contratti agrari in Italia, Torino: Unione Tipografico-Editore.
Saracco Previdi E. (1992), La presenza monastica nelle Marche. L’esempio di S. Croce al Chienti tra IX e XIII secolo, in Le abbazie delle Marche. Storia e Arte, a cura di E. Simi Varanelli, Roma: Viella, pp.159-248.
Sahler H. (2010), Santa Croce del Chienti. Eine Spätkaroligische Reischsabtei in den Italianischen Marken, in Roma Quanta Fuit. Beiträge zur architektur-, Kunst-und Kulturgeschichte von der Antike bis zur Gegenwart, a cura di A. Dietl, G. Dobler, S. Paulus, H. Schüller, Augsburgh: Martin-Luther-Universitat Halle-Wittenberg, pp. 373-422.
Schiaparelli L., a cura di (1906), I Diplomi di Guido e Lamberto, Roma: Istituto Storico Italiano per il Medioevo.
Verdini M. (2014), Problemi di insediamento nella valle del Chienti: il caso della basilica imperiale di Santa Croce, Casette d’Ete Sant’Elpidio a Mare (FM): GraficheFioroni.
Fonti edite
CCF I = Le carte dell’abbazia di Chiaravalle di Fiastra. I (1006-1180), a cura di A. De Luca, Spoleto 1997.
CCF II = Le carte dell’abbazia di Chiaravalle di Fiastra. II (1181-1200), a cura di De Luca A., Spoleto 2013.
CCF III = Le carte dell’Abbazia di Chiaravalle di Fiastra, III (1201-1216), a cura di G. Avarucci, Spoleto 1997.
CCF IV= Le carte dell’Abbazia di Chiaravalle di Fiastra. IV (1217-1230), a cura di C. Maraviglia, Spoleto 2001.
CCF V = Le carte dell’Abbazia di Chiaravalle di Fiastra. V (1231-1337), a cura di G. Borri, Spoleto 1998.
CCF VI = Le carte dell’Abbazia di Chiaravalle di Fiastra.VI (1238-1246), a cura di G. Borri, Spoleto 2000.
CCF VII = Le carte dell’Abbazia di Chiaravalle di Fiastra.VII (1247-1255), a cura di G. Avarucci, G. Borri, Spoleto 2004.
CCF VIII = Le carte dell’Abbazia di Chiaravalle di Fiastra.VIII (1256-1265), a cura di G. Ancidei, Spoleto 2104.
IS II = Italia Sacra, vol. II, a cura di F. Ughelli, Venezia, 1717.
MGH I = Monumenta Germaniae Historica. Diplomatum regum et imperatorum Germaniae, Tomus I, Hannover 1879-1884.
MGH II = Monumenta Germaniae Historica. Diplomatum regum et imperatorum Germaniae, Tomus II, Hannoverae 1893.